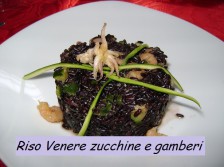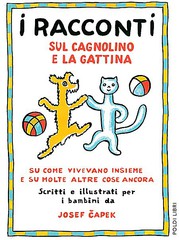Articolo di Dott.ssa Stefania Mella su LEA vol.4/2015
Dal diario di una piccola comunista.
Ricostruzione della vicenda umana
nella Cecoslovacchia di Husák
Stefania Mella
Università degli Studi di Padova (<stefania.mella@unipd.it>)
Abstract
This article aims to present Dal diario di una piccola comunista (From
the diary of a young communist girl), the first novel by the Slovak writer
Michaela Šebőková. Through the main character’s voice, the eleven-yearold
Alžbeta,
Šebőková portrays Czechoslovakian society in the years of
“normalization” and also offers a deeper understanding of children’s
ideological manipulation under the regime of Gustav Husák through
to the Young Pioneers Organization. Growing up as a member of this
organization, Alžbeta, initially driven by strong Communist ideals, ends
up realizing the undeniable contradiction between Communist rhetoric
and its actual behaviour. She will reach awareness that lies and pretence
are the only values underpinning the communist system of those years.
Keywords: autofiction, everyday life, Gustav Husák, normalization, pioneers
Jen malé dějiny lidem umožňují pochopit se napříč různými
dobami.
(Šimečka 1992 [1985], 23)1
LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, n. 4
(2015), pp. 579-588
DOI:
http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-17723
ISSN 1824-484X (online)
http://www.fupress.com/bsfm-lea
2013 Firenze University Press
580 stefania mella
La letteratura, e più ampiamente l’arte, rappresenta uno dei più preziosi strumenti
di conoscenza: senza lo studio della storia e delle opere d’arte sapremmo ben poco
della vicenda umana. Lo scrittore ceco naturalizzato francese Milan Kundera (n. 1929)
osservava da canto suo nel saggio del 1986, L’Art du roman (L’arte del romanzo, 1988),
come dal momento della sua origine (ovvero dall’inizio dell’epoca moderna) il romanzo
sia pervaso dalla “passion de connaître” (Kundera 1986, 20; trad. it. di Marchi 1988:
“passione delconoscere”, 18): molte opere prosastiche rappresentano infatti veri e
propri
documenti che ci permettono di venire a conoscenza di determinate situazioni
e realtà storiche, sociali e culturali. Questo è il caso di Dal diario di una piccola
comunista (Šebőková 2013), un romanzo ambientato nella Cecoslovacchia
degli
anni della normalizzazione di Gustav Husák (1913-1991), per essere precisi
nell’ultimo lustro degli anni Ottanta, pochissimi anni prima della Sametová
revoluce (Rivoluzione di Velluto), o Nežná revolúcia (Rivoluzione gentile), come
venne denominata dagli slovacchi, ovvero la rivoluzione non violenta che ebbe
luogo dal 16 novembre al 29 dicembre 1989 e che portò alla dissoluzione del
regime comunista cecoslovacco (Shepherd 2000). L’abilità della sua autrice, la
scrittrice slovacca Michaela Šebőková (n. 1975), dal 2001 risiedente in Italia,
sta nell’aver sintetizzato la mera quotidianità, l’essenza dell’esistenza della gente
comune negli anni del regime comunista cecoslovacco: l’obiettivo della sua
cinepresa è stato infatti posizionato su vicissitudini apparentemente anodine
di persone semplici che possono assurgere ad alter-ego della maggior parte dei
cittadini della Cecoslovacchia d’allora, di individui che non si personificano negli
archetipi dell’eroe e che non hanno concorso a delineare direttamente il corso
della “grande storia”, nonostante proprio l’amalgama delle loro micro-esistenze
abbia lasciato una significativa impronta indelebile nella “grande storia”,
dilatandosi sulla macroesistenza del regime comunista.
Dal diario di una piccola comunista è il romanzo d’esordio di Michaela
Šebőková, sebbene lei si sia avvicinata alla scrittura già prima, pubblicando
una serie di racconti come ad esempio “Il profumo della domenica”, con il
quale ha vinto nel 2012 il Premio Speciale Slow Food all’interno del Concorso
Letterario Nazionale Lingua Madre, un concorso riservato a donne straniere che
risiedono in Italia e che si cimentano con la scrittura in lingua italiana per
approfondire il tema dell’identità e delle radici (Finocchi 2012,
241-245). Inoltre dal novembre 2014 la Šebőková collabora con Buongiorno
Slovacchia (<http://www.buongiornoslovacchia.sk/>) un giornale
quotidiano
online fondato nel 2009 che presenta notizie legate alla Slovacchia e che costituisce
di fatto il più vasto archivio disponibile in rete di informazioni in
lingua italiana sulla suddetta nazione. Vale la pena menzionare infine che la
Šebőková, grazie al suo lavoro di traduzione, ha reso accessibile ai lettori
italiani la celebre raccolta di racconti per bambini di Josef Čapek (1887-1945),
Povídání o pejskovi a kočičce (Čapek 1929), uscita verso la fine del 2014
con
il titolo Racconti sul cagnolino e la gattina. L’aver scelto
l’italiano per dar vita
ai suoi racconti e al suo romanzo colloca l’autrice all’interno del filone della
“letteratura della migrazione” o “scrittura migrante”, un filone all’interno del
quale possiamo annoverare molti altri scrittori, tra i quali il summenzionato
Milan Kundera o la slovacca Jarmila Očkayová (n. 1955), che dopo il loro
arrivo rispettivamente in Francia e in Italia hanno utilizzato la lingua della
loro nuova patria per redigere le loro opere (ad essere precisi la Očkayová
alternerà per dieci anni la scrittura in slovacco e in italiano, decidendo poi di
optare esclusivamente per quest’ultima lingua), oppure possiamo citare anche
l’ungherese naturalizzata svizzera Ágota Kristóf (1935-2011) che, analogamente
a Michaela Šebőková, ha abbracciato l’attività letteraria solo dopo aver
abbandonato il proprio paese, debuttando direttamente in francese – e in
italiano nel caso della nostra scrittrice. Il carattere migratorio dell’opera della
Šebőková non fa riferimento solamente alla scelta linguistica adottata, ma
anche alla tematica dominante della sua produzione prosastica, che andrà a
costituire de facto
il trait d’union dei suoi racconti. L’esperienza emigratoria
diventa infatti sorgente di profonda ispirazione e porta a condurre una riflessione
non solo sulle dinamiche relazionali che si intrecciano tra gli individui
all’interno della società d’approdo, ma anche sulle complesse ricomposizioni
del sé a partire dallo strappo biografico esperito con la dipartita dal paese
d’origine e con gli anni giovanili. Questa volontà di riflettere sull’infanzia, di
toccare nuovamente con mano l’esperienza passata venata da una pungente
nostalgia è alla genesi del romanzo Dal diario di una piccola comunista, come
si evince nella sua introduzione, dove l’autrice afferma di voler “rievocare i
sapori, gli odori e le vicende della mia adolescenza” (Šebőková 2013, 14). Il
modello narrativo adottato dalla scrittrice, che si avvale di giochi di rimandi
tra la finzione e l’autobiografia, di un groviglio nel quale l’elemento immaginativo
si combina con il fatto personale e soprattutto storico, rimanda all’autofiction: si
tratta infatti di un romanzo a metà fra cronaca lineare di avvenimenti vissuti e la loro
distorsione romanzesca, un romanzo basato sull’interdipendenza fra realtà e finzione
artistica in cui l’intento di sincerità si combina con l’uso di una maschera finzionale2.
Se in questo romanzo la microstoria è forgiata anche da reminiscenze contraffatte,
la macrostoria – sullo sfondo della quale si stagliano i fatti narrati – ricalca alla perfezione
il fluire storico e tutto ciò ad esso connesso: in quest’opera che prende la forma di
diario Michaela Šebőková ripercorre attraverso gli occhi della sua alter-ego,
un’undicenne di nome Alžbeta, la storia della sua famiglia nell’arco di tempo
che va dall’agosto 1986 al dicembre 1987. Mediante la registrazione di numerosi e
minuziosi flash quotidiani, questa bambina così perspicace e così
attenta ai particolari riesce a svelare molti dettagli della vita nella Cecoslovacchia sotto
il regime di Gustav Husák che, eletto segretario generale del Comitato centrale del
Partito Comunista nell’aprile 1969, traghettò il paese
attraverso l’era della cosiddetta normalizace (normalizzazione), uno sviluppo
politico che mirava ad abbattere le riforme avute a partire dagli anni Sessanta,
quando il popolo cecoslovacco era riuscito gradualmente a liberarsi dei
vari diktat ideologici fino a conoscere la sua “fioritura
primaverile” negli otto
mesi iniziali del 1968, prima che le truppe del Patto di Varsavia invadessero
il paese nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, seppellendo così definitivamente le
grandi potenzialità e le fervide speranze germogliate sin dalla precedente primavera
(Caccamo, Tria, Helan 2011). L’obiettivo della normalizzazione era il “ristabilimento
dell’ordine”, come ebbe a definirlo anche il filosofo e critico letterario
Milan Šimečka (1930-1990) nel suo
volume del 1977,
Obnovení pořádku (Lezioni per il ristabilimento dell’ordine, 1982), in
cui
analizza lo sviluppo politico successivo al 1969, esprimendo di fatto il proprio
scetticismo verso ogni costruzione ideologica (Šimečka 1982). Il “socialismo
dal volto umano” promosso da Alexander Dubček (1921-1992) durante la
Primavera di Praga3 venne dunque ribattezzato “stalinismo dal volto umano”:
umano perché questo nuovo regime era sì repressivo, ma non causò lo stesso
spargimento di sangue che aveva caratterizzato i processi politici degli anni
Cinquanta4. Ci fu comunque nuovamente una completa identificazione tra
Stato e Partito Comunista, con la reintroduzione del cosiddetto realismo
socialista che tendeva ad annullare le libertà e i diritti individuali anche
attraverso un’operazione di chiaro indottrinamento ideologico mirato a
qualsiasi fascia d’età della popolazione, in primis i bambini,
ovvero coloro
che sarebbero divenute le nuove leve e che proprio per questo esigevano un
accurato e certosino ammaestramento ai dettami del socialismo. A collaborare in questo
processo “formativo” rivolto ai bambini ci saranno non solamente le istituzioni scolastiche,
chiaramente monitorate dall’alto, ma anche la letteratura d’infanzia, che elaborava tematiche
che dovevano consolidare un atteggiamento propositivo verso il socialismo, come le riviste di
narrativa indirizzate ai lettori più giovani, tra le quali Mateřídouška (Timo), che esce tutt’ora
– sebbene segua, fortunatamente, altri canoni educativi – e il cui primo numero risale al 1945.
Proprio per rendersi conto dell’azione propagandistica del regime comunista durante gli anni
stalinisti è emblematico il numero del dicembre 1949, la cui copertina non è stata occupata
dall’immagine di Ježíšek (Bambino Gesù) e nemmeno da quella di Děda mráz (Nonno Gelo),
il tradizionale portatore di doni nel folklore natalizio russo e, per influsso sovietico durante il
periodo del regime comunista, anche negli altri paesi satelliti, bensì dal
carismatico primo piano di Stalin, che sotto i baffi oramai canuti accennava un
lieve sorriso di segreto compiacimento per il suo settantesimo compleanno.
L’idolatria, infatti, non ammetteva rivali: per riprendere le parole usate da Michaela Šebőková
nel suo romanzo, “il partito era molto geloso” (Šebőková 2013,
23); l’unica Bibbia era il marxismo-leninismo e Dio non faceva parte degli
insegnamenti del Partito Comunista, che si occupava però diligentemente
della formazione politica dei suoi cittadini sin dalla prima elementare, anche
attraverso attività extra-scolastiche “pedagogiche” e “ricreative” che i bambini
eseguivano nel loro tempo libero, e un ruolo precipuo veniva svolto dalla
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (Unione socialista dell’organizzazione
giovanile dei pionieri). Fondata nel 1949, questa organizzazione
giovanile del Partito Comunista della Cecoslovacchia per ragazzi dagli 8 ai 15
anni (poi nel periodo compreso tra i 15 e i 25 anni i giovani cechi e slovacchi
passavano all’Unione della gioventù cecoslovacca) collaborava con l’ambiente
famigliare e con le istituzioni scolastiche a insegnare ai bambini ad assumere un
comportamento reattivo verso i valori sociali dominanti, come il rafforzamento del
socialismo o il pieno coinvolgimento nella vita politica del paese.
Per riprendere dunque l’immagine scalfita da Karl Marx e Friedrich Engels
nell’incipit del loro Manifest der Kommunistischen Partei (Il manifesto del partito
comunista, 1892) del 1848, lo spettro della manipolazione ideologica
messa
in atto in questo ventennio dall’Organizzazione dei Pionieri s’aggira nelle 350
pagine del romanzo qui in questione, impossessandosi dell’anima della giovane
Alžbeta, animata da ferme credenze e propositi comunisti. In questa cronaca
famigliare, la scrittrice sviluppa un’architettura narrativa basata sull’irriducibile
polarità istinto/ragione, sulla dicotomia irrazionalità/razionalità che si profila
nel contrasto sinergico tra i personaggi di Elena e Alžbeta. Se Elena, la sorella
maggiore, rappresenta “la sognatrice, l’incarnazione di una fata che era finita
per sbaglio sulla Terra, dove camminava a passo di danza e parlava in rima
o cantando. Vedeva solo quella parte di mondo che riusciva ad accettare, il
resto per lei non esisteva proprio. Viveva solo per il suo pianoforte” (ivi, 20),
Alžbeta incorpora “la parte materialista che ancorava Elena alla terra perché
non volasse via” (ibidem). Trincerata dietro lo scudo protettivo
della sua passione,
la musica, Elena rimarrà indifferente a qualsiasi influenza esterna, come
un insetto preistorico incastonato nell’ambra e per questo immune alle lesioni
dettate dal trascorrere del tempo; diverso, invece, il destino che spetterà alla
secondogenita che, non avendo qualità notevoli e non eccellendo in nulla di
preciso, si aggrapperà con tutte le sue forze a quell’unica certezza che sentiva
riguardo la sua vita, ovvero quella di divenire una brava Pioniera:
Ero brava in tutte le materie ma eccezionale in nessuna. Avrei potuto studiare
medicina, legge, economia, scienze politiche, o anche fare la parrucchiera. A undici
anni appena compiuti, l’unica convinzione che avevo riguardo la mia vita era di essere
una brava Pioniera. Per la verità non ero una Pioniera qualsiasi: potevo vantarmi di
essere una capoclasse e avevo il diritto di mostrare quella qualifica con due stelline rosse
sulla divisa. Questo per me significava proprio tutto: sognavo sempre con gli occhi
aperti un mondo migliore. Un mondo trasparente dove tutti sostenevano la verità,
dove non si rubava, dove tutti lavoravano per la patria ed esisteva un codice d’onore e
non c’era gente cattiva e nemmeno delle guerre… Insomma, sognavo il mondo come
ci veniva promesso che sarebbe diventato, se il Partito Comunista avesse avuto la
possibilità di gestire tutti i paesi del globo. In attesa che ciò accadesse, io facevo la mia
piccola parte per plasmare la gente intorno a me, anche se alcuni erano proprio duri a
capire. Forse la missione che mi attendeva era proprio quella di migliorare il mondo,
aiutando il movimento rivoluzionario comunista nella lotta contro l’imperialismo.
Meno male, c’erano ancora tantissimi paesi in cui il comunismo non aveva trionfato!
Altrimenti non mi sarebbe rimasto più niente da fare. Che cosa imbarazzante. Avrei
dovuto cercare un’altra ragione per cui ero nata. Così invece, potevo tranquillamente
diventare prima una Pioniera esemplare, poi un’Unionista formidabile e a diciotto
anni una Comunista, istruita e prontissima alla lotta. Decisi che avrei fatto ogni giorno
un’opera buona, da vera Pioniera, come i Pionieri russi che ci davano l’esempio. In
questo modo avrei contribuito subito e concretamente ai cambiamenti che avrebbero
portato la mia patria verso un futuro roseo, comunista. (Ivi, 21-22)
La diligenza che Alžbeta nutre nei confronti dell’Organizzazione dei Pionieri
percorrerà come un filo rosso l’intero romanzo e verrà immortalata nelle esposizioni
descrittive che intersecano ripetutamente la trama e che rappresentano la
cifra stilistica di Michaela Šebőková: il frequente indugiare da parte dell’autrice
su sequenze illustrative impreziosite anche dei più impercettibili particolari
sembra quasi voler ricalcare la minuziosità della piccola protagonista, che cerca
di fare tutto il possibile per curare ogni minimo dettaglio al fine di divenire
una Pioniera e una studentessa modello, apportando il proprio contributo
all’edificazione del futuro comunista. La giovane, dunque, verrà immortalata
nell’atto di preparare e indossare accuratamente la divisa da Pioniera e “come
sempre, quando la maneggiavo o la indossavo, mi sentivo migliore, più pura,
predestinata a grandi cose” (ivi, 78); oppure verrà tratteggiato il suo atteggiamento
da perfezionista quando custodiva i suoi libri come fossero delle reliquie,
non appuntandosi mai nulla, non piegando gli angoli delle pagine, prestando
attenzione a non macchiare le candide facciate con gocce di bibite o briciole di
cibo. E sarà forse anche grazie a questa diligenza che non tarderà ad arrivare la
sua nomina a Presidente del Consiglio Provinciale dei Pionieri, il cui compito
verteva in sostanza non solo nel rappresentare la scuola a livello provinciale ma
anche nel fare le veci dell’intera provincia alle riunioni regionali e nazionali. A
mano a mano che comincerà a muoversi all’interno di questa organizzazione, e
quando le sue partecipazioni alle riunioni dei Consigli Provinciali e Nazionali
si faranno sempre più frequenti, Alžbeta inizierà gradualmente a rendersi conto
che i grandi ideali che la animano, in primis la verità, si
scontrano con la realtà
del totalitarismo e con l’ipocrisia di un sistema farraginoso e incomprensibile.
La progressiva acquisizione della consapevolezza che l’Organizzazione dei
Pionieri non fosse altro che “una grossa bolla di sapone, vistosa ma vuota” (ivi,
322) permeerà l’ultima parte del romanzo, costellata da una serie di aneddoti
che enfatizzano il cambiamento che attanaglia l’animo della ragazzina la quale,
riprendendo l’immagine usata dalla scrittrice, si sta trasformando da bruco in
farfalla, librandosi in volo con le proprie ali. Attraverso il prisma della propria
obiettività non solo vedrà in una nuova luce i membri ai vertici di tale organizzazione,
marionette nelle mani del Partito, ma percepirà anche come la
retorica promossa da questa istituzione e dall’intera struttura statale fosse in
contraddizione con la loro prassi comportamentale:
Come ultimo punto del programma, ci toccò una riunione. Speravo ci mostrassero
qualche
proiezione, invece i tre responsabili presenti (gli adulti erano
in una sala
diversa) vollero che ognuno di noi spiegasse come si svolgevano le proprie riunioni
mensili. Non ci chiamarono per cognome, ma per il nome della provincia; ognuno
si alzava, si presentava come “Presidente del Consiglio Provinciale della Tale città” e
diceva due frasi. Rimasi molto sorpresa da quello che appresi: tra i ragazzi che avevano
parlato prima di me, compresi i miei amici della regione della Slovacchia Ovest, non
c’era nessuno che facesse la riunione in sole quattro ore, come facevamo noi. Come
minimo, si riunivano per una giornata intera, con tanto di pranzo completo al ristorante;
metà circa si riunivano per due giorni, venerdì e sabato,
ovviamente con tutti
i pasti compresi, alloggiando in una delle strutture del partito nella loro provincia…
Un po’ per il senso di ingiustizia subita, ma sicuramente anche per la sete di verità
che non mi aveva ancora abbandonata, quando chiamarono la mia provincia, Nové
Zámky, mi alzai, mi presentai e dissi brevemente: «A me non piace che le nostre
riunioni durino solo quattro ore. Ci rimane tanto lavoro arretrato che poi dobbiamo
sbrigare in pochi, nei giorni successivi». Bastarono queste due frasi per scatenare un
pandemonio: vollero sapere dettagliatamente dove e quando e come si svolgessero le
nostre riunioni, e due di loro prendevano ferocemente appunti. Capii che, per chissà
quale motivo, qualcosa di ciò che avevo detto non andava bene, ma non mi rendevo
conto di cosa e del perché. Mezz’ora dopo aver finito la riunione, mentre sostavamo
nell’atrio, fui avvicinata dalla compagna Martincová. Mi prese per il gomito, mi
strattonò con furia omicida in un angolo deserto, mi costrinse a guardarla negli occhi
ridotti a due fessure e mi soffiò in viso, velenosa: «D’ora in poi mai, e ripeto mai, ti
devi azzardare a dire qualcosa che non hai prima chiesto a me. Hai capito? Dico a te,
hai capito?». La guardai con un’espressione vacua, me ne rendevo conto, ma quello che
stava accadendo non mi sembrava vero. Dov’era finito l’insegnamento dei Pionieri?
E le regole che dovevano tenere in piedi l’amata patria? Essere giusti, dire la verità…
Allora verità, onore, giustizia, erano solo parole vuote?… Quando mi scosse per la
terza volta tirandomi la camicia mi ripresi abbastanza da rispondere: «Ho capito» così
piano che mi costrinse a ripeterlo ad alta voce. Dopo si girò, si guardò intorno per
controllare se qualcuno avesse notato il nostro “dialogo”; tranquillizzata, mi disse:
«Partiamo tra due ore» e se ne andò. Con lei se ne andò anche una parte del mio
cuore. Non perché amassi particolarmente la compagna Martincová, ma perché amavo
più di qualsiasi cosa il nobile Credo dei Pionieri: migliorare il mondo, migliorando
ogni giorno noi stessi. Questo Credo era stato appena calpestato selvaggiamente, e
io compresi che la divisa e quello che essa rappresentava per me non avrebbero mai
più avuto lo stesso significato. (Ivi, 300-302)
Da qui la consapevolezza acquisita da Alžbeta della menzogna e della
finzione come unici valori egemonici dell’apparato statale di quegli anni, che
sfocerà in una sua disillusione sul ruolo del comunismo e sul suo sistema di
assurda e violenta burocrazia. Dirà infatti la scrittrice attraverso la voce della
protagonista: “bisognava saper fingere e tacere; solo in tal modo era possibile
non inimicarsi nessuno e approfittare delle possibilità offerte, essere invisibili
ma ben visti, apprezzati ma non invidiati” (ivi, 351). E poi ancora: “io non
sarei mai diventata un pollo che si lascia ingrassare e poi ammazzare senza lotta.
Prima o poi avrei buttato giù il coperchio di falsi insegnamenti e piuttosto
che farmi fermare sarei volata via, per vedere se più lontano dal nido ci fosse
un mondo migliore” (ivi, 352). Il romanzo si chiude con questa immagine e
non è un caso che l’autrice, nel distico introduttivo del libro, riporti la celeberrima frase
“Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí” (La verità e l’amore
vinceranno sulla menzogna e sull’odio) di Václav Havel, il primo presidente
della Cecoslovacchia democratica post-comunista ma anche – e soprattutto –
l’intellettuale che ha animato il palcoscenico culturale cecoslovacco durante gli
anni cupi e tristi del comunismo, divenendo uno dei principali esponenti del
dissenso cecoslovacco e portavoce dei valori quali integrità, libertà e onestà5.
Dal diario di una piccola comunista è dunque un romanzo in cui Michaela
Šebőková
proietta la parabola della crescita personale della protagonista, tutt’altro che avulsa
dal contesto sociale e politico, e sullo sfondo di
tale processo di maturazione si annidano minuziosi dettagli della vita della
sua famiglia, andando quindi a formare una prosa documentale della realtà
storico-sociale d’allora, oltre che delle tradizioni culturali e culinarie slovacche
sulle quali l’autrice si sofferma spesso e a lungo. Figura centrale del romanzo
non è dunque unicamente Alžbeta con il suo percorso di crescita personale;
protagonista dell’opera è anche un intero mondo, quello della regione slovacca
durante il regime comunista, con la sua cultura e la sua cucina, strettamente
legate alla realtà ungherese.
Per concludere vale la pena evidenziare come il romanzo al centro di
questo studio, sebbene apparso nel mercato editoriale italiano, rispecchi una
delle tendenze in atto a partire dagli anni Novanta nella prosa di estrazione
cecoslovacca (specialmente ceca), ovvero uno sviluppo romanzesco incentrato
sulla coordinata temporale comunista, frutto di autori appartenenti perlopiù
alla generazione degli anni Sessanta e Settanta, affacciatisi sulla scena letteraria
del paese negli anni successivi la Rivoluzione di velluto e che hanno sentito
il bisogno di rielaborare la vicenda totalitaria da essi stessi vissuta durante la
loro giovinezza adottando la prospettiva narrativa infantile e/o adolescenziale.
Questo trend, inaugurato nel 1992 da Michal Viewegh (n. 1962) con
il suo
bestseller dal titolo ironicamente ossimorico Báječná léta pod psa
(Quei favolosi
anni da cane, 2001), dove i “favolosi anni” della giovinezza si
intrecciano
agli “anni da cane” vissuti dalla società cecoslovacca (Karfik 1993), si profila
nei romanzi di altri scrittori come ad esempio in Hrdý Budžes (1998; Sarai
fiero) di Irena Dousková (n. 1964), che analogamente a Michaela Šebőková
tratteggia attraverso la voce di una ragazzina di otto anni la quotidianità di
un’ordinaria famiglia cecoslovacca dei primi anni della normalizzazione,
Brambora byla pomeranč mého dětství (2001; La patata è stata l’arancia
della
mia infanzia) di Bohuslav Vaněk-Úvalský (n. 1970) e Se srpem v zádech, aneb,
Malé dějiny posranosti (2004; Con la falce nella schiena ovvero Piccola
storia
di un sentimento di fifa) di Jiří Pilous (n. 1958). All’interno di questa volontà
di raffigurare e preservare la memoria collettiva dell’esperienza comunista
filtrata attraverso la prospettiva infantile si inserisce la raccolta uscita a fine
2014 Mé dětství v socialismu (La mia infanzia sotto il socialismo),
dove in
occasione dei venticinque anni dalla caduta del regime comunista il giornalista
Ján Simkanič ha riunito una sessantina di memorie di personalità del
mondo della cultura ceca vissute tra gli anni Cinquanta e Ottanta, alcune
delle quali ricordano con nostalgia la vita di allora, in un gioco di sfumature
e di rimandi in cui le storie drammatiche si alternano a quelle divertenti,
conferendo all’antologia un tono pressoché tragicomico (Simkanič 2014).
Ora che tra la giovane generazione di prosatori cechi, come mette in luce la
scrittrice Markéta Pilátová (n. 1973), è in atto una tendenza alla fuga, ovvero
una propensione a distanziarsi da qualsiasi legame con la contemporaneità
e con il periodo trascorso per raggiungere nuovi orizzonti esotici (Pilátová
2009), la componente testimoniale che trasuda dalle pagine dei romanzi quali
Dal diario di una piccola comunista sembrano essere, in campo
letterario,
l’unico baluardo contro la cancellazione e l’oblio.
(Se non diversamente specificato tutte le traduzioni sono di chi
scrive).
1Trad. it.: Solo la piccola storia permette alle persone di intendersi
attraverso le varie epoche.
2Il termine autofiction, di
origine francese, è stato coniato nel 1977 dallo scrittore francese
Serge Doubrovsky (n. 1928), che lo riportò sulla quarta di copertina del suo romanzo Fils
(Figlio). Tuttavia in Francia erano già stati pubblicati due studi che avevano analizzato
il
dispositivo autofinzionale: nel 1953 era uscito infatti il
saggio Le degré zéro de l’écriture (Il grado
zero
della scrittura, 1960) del critico letterario Roland Barthes e nel 1975 Le pacte
autobiographique
(Il patto
autobiografico, 1986) di Philippe Lejeune, volume che determinò a distanza di due
anni la scrittura di Fils e l’avvio ufficiale della storia del termine autofiction. Si veda il volume
Autofiction Père & Fils: S. Doubrovsky, A. Robbe-Grillet, H. Guibert (Samé 2013; Autofiction
Padre e Figlio: S. Doubrovsky, A. Robbe-Grillet, H. Guibert).
3 Si consulti Naděje umírá
poslední: vlastní životopis Alexandra Dubčeka (Dubček 1993;
Il socialismo dal volto umano: autobiografia di un rivoluzionario, trad. it. di Antonetti 1996).
4Si veda, ad esempio, il
volume Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého
centra na čele s Rudolfom Slánskym (Löbl 1969; Testimonianza sul processo Slánský, trad. it. di
Ruggeri 1969).
5 Per un approfondimento si veda la sezione “Václav Havel: Uscire di scena” della rivista
eSamizdat (Catalano, Cosentino 2012-2013).
LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, n. 4 (2015), pp.
579-588
DOI: http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-17723
ISSN 1824-484X (online)
http://www.fupress.com/bsfm-lea
2013 Firenze University Press
580 stefania mella
Riferimenti bibliografici
Barthes Roland (1953), Le degré zéro de l’écriture, Paris, Ed. du Seuil. Trad. it. di
Giuseppe Bartolucci (1960), Il grado zero della scrittura, Milano, Lerici.
Caccamo Francesco, Tria Massimo, Helan Pavel, a cura di (2011), Primavera di
Praga,
risveglio europeo, Firenze, Firenze UP.
Čapek Josef (1929), Povídání o pejskovi a kočičce. Jak spolu hospodařili a ještě o
všelijakých
jiných věcech, Praha, Dr. O. Štorch-Marien. Trad. it. di Michaela Šebőková
(2014), I racconti sul cagnolino e la gattina. Su come vivevano insieme e su
molte
altre cose ancora, Padova, Poldi Libri.
Catalano Alessandro, Cosentino Annalisa, a cura di (2012-2013), “Václav Havel:
Uscire di scena”, eSamizdat, IX, 139-242, <http://www.esamizdat.it/rivista/2012-2013/index.htm> (09/2015).
Dubček Alexander (1993), Naděje umírá poslední: vlastní životopis Alexandra
Dubčeka,
Svoboda-Libertas, Praha. Trad. it. e cura dall‘inglese (Hope dies Last. The Auto-
588 stefania
mella
biography of Alexander Dubček, 1993) di Luciano Antonetti (1996), Il socialismo
dal volto umano. Autobiografia di un rivoluzionario, Roma, Editori Riuniti.
Finocchi Daniela, a cura di (2012), Lingua Madre Duemiladodici. Racconti di
donne
straniere in Italia, Torino, Edizioni SEB 27.
Karfik Vladimir (1993), “Báječná léta pod psa”, Literární noviny, 10, 7. Trad. it. di
Alessandro Catalano, Quei favolosi anni da cane, Milano, Mondadori 2001.
Kundera Milan (1986), L‘art du roman, Paris, Gallimard. Trad. it. di Ena Marchi
(1988), L’arte del romanzo, Milano, Adelphi.
Lejeune Philippe (1975), Le pacte autobiographique, Paris, Seuil. Trad. it. di Franca
Santini (1986), Il patto autobiografico, Bologna, il Mulino.
Löbl Eugen (1969), Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra
na
čele s Rudolfom Slánskym, Bratislava, Vydavateľstvo politickej literatúry. Trad. it. di
Giovanni Ruggeri (1969), Testimonianza sul processo Slánský, Firenze, Vallecchi.
Pilátová Markéta (2009), “Spisovatelé na útěku” (Scrittori in fuga), Respekt, 18, 36-41.
Samé Emmanuel (2013), Autofiction Père & Fils: S. Doubrovsky, A.
Robbe-Grillet,
H. Guibert (Autofiction Padre e Figlio: S. Doubrovsky, A. Robbe-Grillet, H.
Guibert), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon.
Šebőková Michaela (2012), “Il profumo della domenica”, in Daniela Finocchi (a cura
di), Lingua Madre Duemiladodici. Racconti di donne straniere in
Italia, Torino,
Edizioni SEB 27, 241-245.
— (2013), Dal diario di una piccola comunista, Lecce, Besa Editrice.
Shepherd Robin E.H. (2000), Czechoslovakia: The Velvet Revolution and
Beyond,
Houndmills, Macmillan Press.
Simkanič Ján, a cura di (2014), Mé dětství v socialismu (La mia infanzia sotto il socialismo), Brno, BizBooks.
Šimečka Milan (1979 [1977]), Obnovení pořádku, Köln, Index; (1990), Brno, Atlantis.
Trad. it. e note di Lesní Kámen (1982), Lezioni per il ristabilimento
dell’ordine.
Contributo alla tipologia del socialismo reale, introduzione di Jirí Pelikan, Roma,
Edizioni E/O.
— (1992 [1985]), Kruhová obrana (Difersa circolare), Bratislava, Archa.